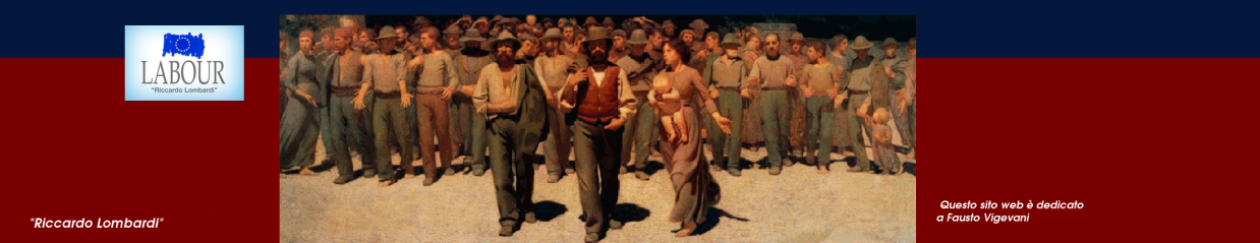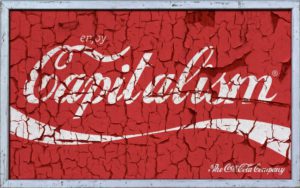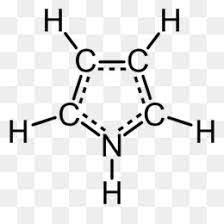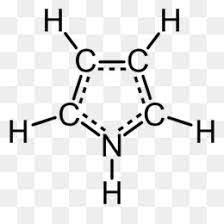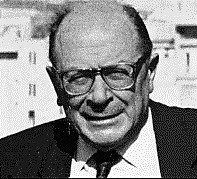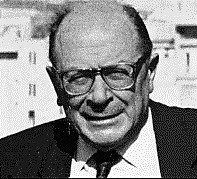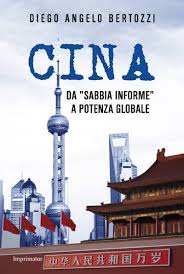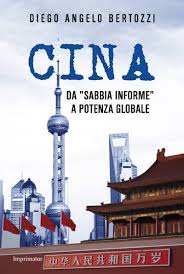Di Giuseppe Giuduce, 13 settembre 2023

Non so se il termine ecosocialismo sia corretto o meno. Talvolta viene utilizzato come un’implicita critica al socialismo tourt-court. Quando invece concerne l’attualizzazione della ragion d’essere del socialismo , come progetto di emancipazione sociale delle classi subalterne basato su una critica strutturale al capitalismo odierno. C’è infatti un ecologismo acritico che si bada bene di contestare le radici dei gravissimi problemi ambientali che mettono in pericolo la sopravvivenza della specie umana. le radici stanno nel meccanismo di sviluppo e crescita del capitalismo, del suo modo di produrre e consumare. che da un lato generano enormi ingiustizie e disuguaglianze , nonché un super-sfruttamento del lavoro, dall’altro infligge ferite mortali all’ecosistema. Oggi il conflitto con il capitalismo unisce in modo sistemico questione sociale e questione ambientale. E il capitalismo odierno è un sistema globale. Capitalisti sono gli USA, capitalista è la Cina (dove ci sono più di 500 miliardari in dollari), capitalisti sono la Francia, la Germania , la GB: capitalista è l’India. Sono capitalismi che hanno le loro peculiarità ma perseguono gli stessi obiettivi.
IL conflitto contro il capitalismo non può che essere un conflitto globale che prospetti un progetto di società alternativo. A tale proposito propongo diversi passi di un libro-intervista che Riccardo Lombardi rilasciò allo storico socialista Carlo Vallauri nel lontanissimo 1976 e che forse esprime la migliore sintesi del suo pensiero (faccio notare che il libro è stato ristampato nel 2009 con introduzione di Fausto Bertinotti ). In tale passo Lombardi, per primo , nella sinistra, contesta lo sviluppismo, discetta sui limiti fisici e naturali della crescita, legandoli strettamente alla critica profonda al capitalismo. Espongo i passi:
” Quando si parla di sacrifici bisogna guardare un po’ più lontano, e bisogna pensare che noi ci avviamo rapidamente ad una situazione mondiale in cui tutte le classi dovranno rivedere i loro modi di vita poiché non è consentito – ed ogni giorno se ne avverte di più l’impossibilità – che, alla lunga, si possa pensare di lasciare tre quarti del mondo affamati ed un quarto in condizioni di super consumo…
Una società capitalista … si distingue da una socialista…per la diversità della ricchezza. Più ricca perché diversamente ricca. …Pensare che l’Europa capitalista possa inseguire un modello di sviluppo di crescenti consumi in modo da… eguagliare gli Stati Uniti d’America, è un non senso, perché uno sviluppo di questo genere non può essere fisicamente sopportato dal mondo…
Non dobbiamo dimenticare che…le risorse energetiche, le materie prime…avranno costi di estrazione sempre maggiori, quindi piu cari. Si porrà perciò un problema di permanente difficoltà. Penso che non si possa continuare in un modello di sviluppo che è fatto di sprechi organizzati. Si fabbricano beni di consumo deliberatamente deperibili – a parte quel bene di consumo, per definizione per definizione obsoleto fin dalla nascita, che è l’armamento – perché l’interesse produttivo è rivolto a costruire con un massimo spreco di materie prime, a costruire beni facilmente deperibili e quindi sostituibili, per alimentare continuamente il mercato…
Il modello neo capitalista non funziona se non con un rinnovamento incessante e tumultuoso dei consumi e, quindi, con uno spreco immenso di risorse e di materie prime. Se l’Europa dovesse inseguire questo modello…saremmo freschi!
Questo non è fisicamente sopportabile, non è politicamente sopportabile dal resto del mondo, che ne pagherebbe il costo, e non è sopportabile dall’indisponibilità di risorse a prezzi sufficienti per poter alimentare questo spreco continuato. Qui bisogna prepararsi a tutto un modello diverso di consumi.”….Che fare?
“…come indirizzo generale, i mutamenti dovrebbero consistere, intanto, nel rendere la produzione italiana meno dipendente, meno indirizzata verso gli scambi con l’estero…Poi una maggiore domanda pubblica interna e soprattutto una domanda per servizi sociali…
L’altro indirizzo è quello del risparmio delle materie prime che implica il ricorso – si può dire quasi rivoluzionario, in quanto in contraddizione con la logica del sistema, – alle fabbricazioni di beni meno deperibili di quelli deliberatamente deperibili che fanno adesso…dalle automobili, alle lampade elettriche, alle calze di nylon…Certo costerebbero di più ma con minor spreco di materie prime, il costo d’acquisto maggiore sarebbe compensato dal più lungo ammortamento…C’è anche una questione di civiltà, quella di risparmiare lavoro utile sprecato nella futilità e nella obsolescenza programmatica…
Credo che soltanto un governo socialista possa resistere alle pressioni perché le cose non mutino, in quanto probabilmente, anzi certamente, il sistema produttivo dilapidatorio consente un mantenimento del meccanismo dei profitti molto più potente di quanto non consenta un sistema di risparmi di risorse.”
Questo nel 1976!!! In parte le problematiche sollevate da Lombardi, sono poi riprese da Giorgio Ruffolo. Nel suo libro più denso “la qualità sociale”. Anche se Ruffolo ragiona nei termini di un nuovo compromesso più avanzato con il capitalismo e Lombardi invece per il superamento del capitalismo stesso. Egli dà un grande contributo per immaginare un modello economico compatibile con gli equilibri ambientali. Del resto Giorgio Ruffolo è stato per 5 anni ministro dell’ambiente dal 1987 al 1992, in quota PSI. Un ministero che Ruffolo trasformò completamente, dandogli sostanza e forza politica. Ruffolo non amava i teorici della decrescita felice (alla Serge Latouche, a sua volta ispirato da Ivan Illich). Il limite dei teorici della decrescita è simmetrico e speculare a quello degli sviluppisti. Essi ragionano solo in termini quantitativi e non qualitativi. Una critica che lo stesso Lombardi avrebbe sottoscritto. Egli infatti pensava che si sarebbe dovuto passare dalla produzione di beni ad alta intensità di profitto, ad un’altra ad alta intensità di utilità …una volta disse che accanto alla caduta tendenziale del tasso di profitto, il capitalismo produceva una caduta dell’utilità marginale delle merci. C’è poco da aggiungere, sulla grande lungimiranza di Lombardi. Del resto la battaglia contro le ingiustizie, e le disuguaglianze del “capitalismo reale” si unisce ad una politica di piano per una vera transizione ecologica dell’economia, nelle “socialdemocrazie di sinistra” di Corbyn e Melenchon.